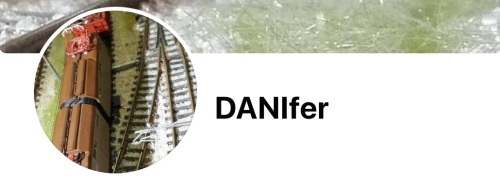Pubblicato il 25 gennaio 2014, ultima modifica 18 settembre 2014
La V 200 è una locomotiva simbolo per varia ragioni: nel mondo reale per aver accompagnato la ricostruzione post-bellica della Germania e per aver marcato il passaggio dall’epoca del vapore alla modernità, nel modellismo per essere stato il modello che segna la nascita della scala N – e non a caso è stata scelta a simbolo di questo blog.
I prototipi 001-005 furono sviluppati congiuntamente dal Bundesbahn-Zentralamts München e da Krauss-Maffei che le costruì. Le poste tedesche, interessate alla consegna veloce notturna, contribuirono sponsorizzando la costruzione di 3 dei 5 prototipi.
Le macchine erano della B’B’ da 2000 cavalli . A quell’epoca l’immatricolazione delle macchine diesel era una V (Verbrennung= combustione) seguito da un numero che ne specificava le decine di cavalli (ad esempio la V36 aveva 360 PS): divennero quindi V200. Dal 1974 l’immatricolazione sarebbe cambiata, passando a 220 – ne parleremo più diffusamente dopo. Potenza e velocità le rendevano adatte alla sostituzione delle motrici a vapore, in particolare delle Br 01, 03 e 39. La potenza (1618 KW) era praticamente identica a quella della Br 01 (1648 KW) e superiore a quella di Br03 (1459 KW) e Br 39 (1190 KW) e con i suoi 140 Km/h era più veloce della più rapida delle tre locomotive (130 Km/h della Br01).
Il primo viaggio ebbe luogo il 21 Maggio 1953, da Monaco-Allach a Ingolstadt e ritorno. I prototipi furono valutati molto positivamente, l’esperienza fatta permise di apportare alcune modifiche minori: aggiunta del terzo faro e variazione di maniglie e fischio. La produzione di serie ebbe luogo affidando la costruzione di altre 81 unità alla Krauss-Maffei e alla MaK (Maschinenwerk Kiel). Le macchine avevano due motori indipendenti, ciascuno agente su un carrello che aveva entrambi gli assi motori. I motori erano di produzione Daimler-Benz, MAN e Maybach. La trasmissione idraulica era prodotta da Maybach e Voith.
Le macchine erano dotate di una caldaia, con relativi depositi di combustibile e acqua, per fornire riscaldamento a vapore alle carrozze.
Le macchine da 001 a 055 erano caratterizzate dalla scritta “Deutsche Bundesbahn” con grandi lettere il rilievo disposte lungo la fiancata. A metà anni ’60 la scritta fu rimossa e sostituita dal logo DB, che le macchine da 56 a 86 ricevettero nativamente. Queste macchine non ebbero nemmeno le strisce in profilato di alluminio che correvano lungo le fiancate e si univano nella “V” frontale, sostituite da una striscia di vernice.

V200.116. Si nota la sostituzione della scritta “Deutsche Bundesbahn” sulla fiancata con il logo DB. Foto © Peter Scokkenbroeck, 2005
Tra il 1962 e il 1965 fu prodotta, in 50 esemplari, una versione con motori più potenti destinata a linee tortuose e acclive. I motori erogavano una potenza incrementata del 20%. Andarono a costituire la serie V 200.1, con numerazione da 101 a 150. La macchina era analoga (più corta di 3 cm), aveva una lubrificazione della flangia della ruota. In montagna però la macchina non fu di successo come lo era stata in pianura, soprattutto per problemi di trasmissione, tanto che in alcuni casi fu necessario ripristinare la trazione a vapore (si veda epoche3.de).
Furono macchine versatili: adatte a treni viaggiatori veloci a lungo percorso , ma anche a servizi diretti e locali reversibili, grazie al loro telecomando per treni navetta. Nella loro tutto sommato non lunghissima ma certamente prestigiosa carriera, le V200 ebbero anche l’onore di trainare sistematicamente dei TEE o altri treni “importanti”, come una tratta del “Rheingold” con destinazione Amsterdam, il “Merkur” Stuttgart – Kobenhavn, tra Hamburg e Puttgarden, anche se, a differenza della Br 218, nessuna di esse ricevette mai la livrea rosso-crema. Anche alcuni dei primi IC cadenzati furono trainati da queste motrici.
Nel 1968 ebbe luogo la riclassificazione del parco DB. Con la nuova classificazione, la prima cifra indicava la motorizzazione ( 0 per le macchine a vapore, 1 per i locomotori elettrici, 2 per i diesel, 3 per le motrici piccole – Köf e affini -, 4, 5 e 6 per le automotrici – rispettivamente elettriche, ad accumulatori e diesel- , 7 per i mezzi di servizio), le due cifre successive erano in genere, e con qualche eccezione, le prime due della numerazione precedente: così le V200.0 divennero 220 e le V200.1 (ecco una eccezione) divennero 221.
Nel 1975 lo schema di colori DB mutò, e le 220 e 221 ricevettero la livrea “Ozeanblu – Creme”.
La progressiva elettrificazione delle tratte ferroviarie spodestò prima e marginalizzò poi queste possenti macchine, che a loro volta erano state in grado di detronizzare le regine del vapore. Dapprima relegate su linee secondarie, furono dismesse all’inizio degli anni ottanta (le 221 resistettero fino al 1988). Ed è proprio a questo punto che inizia la loro diaspora, che dà origine allo loro lunga storia italiana: ormai più lunga di quanto sia stato il periodo alemanno! Del periodo italiano diamo conto estesamente nel seguito. Una interessante serie di fotografie delle V200 all’estero (Spagna, Francia, Jugoslavia ecc.) si trova su locopage.net.
Nel nuovo millennio, il flusso migratorio si è invertito: molte sono le macchine che hanno fatto ritorno in Germania. Alcune sono state restaurate come macchine storiche, altre sono state interamente ricostruite per affrontare una nuova storia. L’intervento più rilevante è stato la sostituzione dei motori, con una coppia di Deutz o di MTU 12V 4000 R 41 R da circa 1,500 hp ciascuno (1,100 kW), per una potenza totale di circa 3000 HP. Le macchine così ristrutturate sono andate a costituire la nuova serie V270, e sono impiegate prevalentemente per lavori di manutenzione di linea o, come nel caso della Arriva Werke Nord Gmbh come locomotiva di soccorso (si veda richardkrol.nl).

La rinata V270.10 veste la livrea originale. Altre V270 hanno livree di vari colori. Foto © Martin Morkowsky da bahnbilder.de
Una lista di tutte le V200.0 si trova su www.lokfotos.de, con foto di quasi tutti gli esemplari. Una schematica storia delle singole macchine di tipo V200.0 si trova su privat-bahn.de e sulle pagine oocities di rolfwiso.
In un’altra pagina di lokfotos.de c’è la lista delle V200.1. Come per le V200.0, anche per le V200.1 si trova documentazione su privat-bahn.de e su oocities di rolfwiso.
Dalle V200 derivarono anche la V300 (Kraus Maffei ML 2200 C’C’). Era stata progettata come modifica delle V200 per abbassarne il peso assiale, distribuendolo su 6 assi anziché su 4, per poterle vendere alle JZ (Ferrovie Jugoslave) che avevano un armamento più leggero. Tre macchine furono infatti acquistate, e immatricolate D 66: successivamente divennero JŽ 761. Furono battezzate con dei nomi: “Dinara”, “Kozara”, e “Sutjeska”. La prima fu usata per il treno presidenziale del Maresciallo Tito. Una quarta motrice, costruita nel 1957 rimase in Germania. Dopo un periodo di sperimentazione, l’anno successivo fu potenziata sostituendo i motori e divenendo Kraus Maffei ML 3000 C’C’. Ebbe una parentesi ungherese, durata dal ’60 al ’63, dove divenne M 61 2001. Tornata in Germania, fu acquistata dalle DB, e divenne la V300.001 (dopo il 1988 la serie fu rinominata Br 230). Come vedremo, fopo la dismissione avvenuta nel 1977 la macchina, ebbe una breve parentesi italiana.

La V.300 – foto © VOBA http://www.bahnen-wuppertal.de
Curiosità
La 137 e una Br50 furono coinvolte in un curioso incidente, documentato dalla seguente foto. Per fortuna nessuno si fece del male! Molti anni dopo la macchina sarebbe passata dalla Fervet di Castelfranco Veneto con destinazione Grecia.

Una V200.1 ed una Br 50 colte in una posizione imbarazzantemente sconveniente… Foto © bilder.strasse-und-schiene.de
Vi fu una sorta di scherzo fatto dalle British Railways. Poiché la cifra “8” e la lettera “B” si somigliano, la D821 può essere letta DB 21. Così nel 1988 ridipinsero la macchina britannica con i colori DB e la marcarono come V200.021! La falsa livrea fu mantenuta fino al 1991. In quel periodo la macchina ebbe vari soprannomi, tra cui “Betruger”: impostore.
Venne progettata, ma restò su carta, una versione con due motrici permanentemente accoppiate.

La doppia V.200, immaginata ma mai realizzata. Foto KM, reperita su forum.e-train.fr
Le V200 in Italia
Vi sono due categorie di motrici che, dopo aver servito all’estero, trovano una seconda vita nel Bel Paese: quelle che divengono macchine da cantiere, e quelle che vengono acquisite per servizi di linea presso ferrovie concesse. Nella prima categoria rientrano ad esempio molte motrici ex-DB, come le 211-213, le V160-Br216, 280, ma anche le NOHAB o le austriache Jenbacher. Nel secondo gruppo troviamo ad esempio le D.361 rumene o le D752-753 Occhialute ceche. Le 220/ V200 appartengono a entrambe le categorie. Sei unità tra il 1981 e il 1984 sono state acquistate da imprese private per lavori all’armamento, e hanno lavorato su varie linee della penisola seguendo i cantieri per la sostituzione del binario per conto di quattro diverse aziende: Cosfer (tre macchine: 028, 031 e 039), Valditerra (la 060), IPE (la 065), Veltri (la 029). Alcune hanno mantenuto la livrea di origine, altre hanno preso il caratteristico colore giallo delle motrici da cantiere. Nonostante le V200 fossero macchine da pianura, in veste cantieristica hanno scalato i vari pendii italici, dal Brennero ai Giovi alla Maiella. Altre sette, negli stessi anni, furono acquisite da tre diverse concesse: Ferrovia Suzzara-Ferrara (tre macchine: 006, 011, 049), Ferrovie Padane (tre macchine: 041, 045, 074) e SNFT (la 051).
Altre tre furono acquistate da un’azienda emiliana a scopo demolizione (076, 083, 084). Ben 16 delle 85 V200.0 (un quinto del parco) sono dunque migrate da noi. Ne daremo conto dettagliato più sotto. Delle 13 in esercizio, 10 sono poi confluite nel parco FER (Ferrovia dell’Emilia Romagna) dove svolgono ancora servizio attivo. Due sono tornate in Germania dopo varie peripezie, e una è forse stata demolita.
Delle 221, a parte quelle venute in Italia per una revisione prima della loro destinazione albanese o greca – ne parleremo tra poco – , risulta essere stata ad Udine dal 1991 la 108 (da Bulfone – si veda privatbahn.de) per essere poi demolita nel 2000, e la 130, presa in carico da Fervet per la demolizione nel 1994.
Ma riassumiamo la storia delle “padane”. Iniziò La Ferrovia Suzzara-Ferrara (FSF) acquisendo tre motrici (006, 011 e 049). Le macchine erano state revisionate dalle officine DB che le avevano ridipinte nei colori correnti DB (blu oceano e crema), ma con una livrea diversa da quella in uso in Germania per le 220, e che invece ricorda quella dall’aspetto grafico più leggero vestita dalle 218.

La livrea DB delle 210,216,217 e 218, qui indossata dalla 210.004. Foto © Martin Welzel da http://www.drehscheibe-foren.de
Ammesse alla circolazione nel 1983, iniziarono il servizio trainando brevi merci ordinari.
Nello stesso anno le Ferrovie Padane (FP) acquistarono due esemplari (045 e 074) che avevano seguito lo stesso iter delle altre tre macchine e vestivano un livrea identica, che variava solo per il logo FP invece che FSF. Furono presto riverniciate, mantenendo lo stesso schema ma sostituendo il blu oceano con il verde magnolia, per omogeneità con il resto del parco FP.
Ebbero lo stesso impiego delle FSF fino al 1987/88, quando sia FSF che FP acquistarono alcune carrozze radiate dalle SBB, di tipo leggero (Leichtstahlwagen) con due porte per fiancata, e ambiente unico (carrozze dello stesso tipo vennero acquistate dall’ACT di Reggio Emilia, e dalle FNM/SNFT). A questo punto le 220 tornarono ad effettuare servizio passeggeri, in particolare per aumentare la capienza dei convogli per pendolari ove le automotrici non offrivano sufficienti posti. Alcune immagini delle carrozze svizzere si trovano nel prezioso archivo flickr di Johannes Smit.
Nel 1990 FP acquisì la 041 delle officine Bulfone di Udine che l’avevano revisionata dopo il servizio prestato presso la Cosfer.
Dopo alcuni anni (1995/6), le carrozze ex SBB dovettero essere ritirate dal servizio perché coibentate con amianto, ed il servizio passeggeri delle 220 ebbe termine. Le motrici tornarono così la servizio merci, ed in particolare quello dei merci passanti: treni Ravenna – Guastalla via Suzzara per il trasporto di coils di lamiera e di altri prodotti siderurgici. Le potenti 220 effettuarono con successo il compito affidato, che dopo poco venne esteso alla Ravenna-Ferrara e Ferrara-Bologna. In tale servizio motrici FP e FSF si affiancavano e si scambiavano: era solo un’anteprima di quel che di lì a poco sarebbe accaduto, con la “fusione” di FSF, FP e FBP (Ferrovia Bologna Portomaggiore) nella nuova FER (Ferrovie dell’Emilia Romagna).
Quest’ultima sperimentò il revamping di una motrice (la 006) presso le officine Fervet di Castelfranco Veneto, sostituendo i motori con degli Isotta Fraschini a 12 cilindri a “V” da 735 kW ciascuno. Per la verità altre importanti modifiche vennero applicate in questa fase: lo spostamento dei banchi di manovra da destra a sinistra, la climatizzazione delle cabine, l’aggiunta dei dispositivi per il comando multiplo. Poi però FER optò per una diversa soluzione per le restanti macchine, facendo effettuare in Croazia una ristrutturazione che portò a montare due motori Caterpillar D3508 V8 da 810 kW, i convertitori idraulici di coppia Voith L306r ed a rifare a bassa tensione (24 volt) l’impianto elettrico di bordo, sostituendo il sistema di controllo elettromeccanico originale Brown-Boveri, ed adeguando le macchine alle nuove norme. Nel corso di quest’operazione, acquisì altre quattro 220 che si trovavano sul territorio italiano: tre macchine usate in precedenza per cantiere, e la 051 che poca fortuna aveva avuto presso la SNFT sulla linea della Valcamonica, confermando la scarsa idoneità al servizio sulle linee di montagna già evidenziata in Germania. Il revamping fu completato dall’adozione della nuova sgargiante livrea tricolore. Una curiosità in proposito: le macchine hanno tutte livree diverse. La differenza sta nel colore applicato a mo’ di “mascherina e bavaglino” attorno ai finestrini anteriori di cabina.
Secondo Andrea Canale, in Italia trascorsero un breve periodo altre 25 220: si tratta delle macchine destinate a Grecia e Albania, che furono revisionate dalla FERVET di Treviso. Le 5 macchine delle ferrovie albanesi (HSH) furono riverniciate in rosso brillante e rinumerate da 2001 a 2005. Giunte in Albania nel 1989/90, furono tutte accantonate nel 1993, secondo alcuni per la scarsa competenza ed efficienza dei responsabili della manutenzione. Alcune immagini delle motrici in abbandono su marklinfan, una degli anni di esercizio su trains-worldexpresses.
Le macchine destinate alla greca OSE (Organismos Sidirodromon Ellados) erano delle 221. Trasferite in Grecia nel 1989 dopo la revisione Fervet, furono immatricolate (A) 411-430. Avevano livrea simile a quella delle FP e FSF. Furono usate per il servizio passeggeri tra Atene e Salonicco. Anche qui, la manutenzione lasciò a desiderare, e le macchine confermarono la scarsa propensione ai percorsi tortuosi e acclivi: già nel 1996 la flotta si era ridotta a due unità attive e 18 “donatori di organi”! , Nel 2002 le macchine fecero ritorno in Germania per conto di EBW Cargo, come documentato da un filmato.
Citiamo poi le sette macchine passate alla Svizzera e immatricolate SBB Am 4/4 18461-7 (in origine 013-017, 053, 077). Erano utilizzate per condurre treni di manutenzione delle linee, e qualcuna di esse potrebbero essersi spinta fino al confine italiano, anche se non abbiamo trovato evidenza di questa ipotesi .
Un’altra variante della V200 interessò marginalmente l’Italia. Krauss Maffei realizzò la ML2200CC, una CoCo di aspetto molto simile alla V200 – sembrava una V200 allungata. Tre di queste motrici furono vendute alle Ferrovie Jugoslave dove costituirono il gruppo 66. Una macchina, equipaggiata con due motori da 1500 PS e quindi denominata ML3000CC fu venduta alla DB e immatricolata come V300-001 (poi 230-001). Restò un esemplare unico. Entrò in Italia come dimostrativo e fece dei test di prova, nella speranza di convincere FS ad ordinarne, ma ciò non avvenne. Nel 1977, a fine servizio, tornò in Italia presso Bulfone (Udine), ma l’acquisto non fu perfezionato e dopo un anno la macchina tornò in Germania, dove nel 1980 fu smantellata.

V300 ancora con le scritte “Krauss Maffei” sulla fiancata (poi sostituite da “Deutsche Bundesbah) Foto © Herbert Schambach da http://www.bundesbahnzeit.de/
Interessanti articoli complementari a questo sulle V200 in Italia si trovano su photorail e su www.richardkrol.nl.
Dettaglio delle V200 Italiane
006 (FSF – FER)
La V200-006, poi divenuta 220-006-1, fu prodotta da Mak, e fu in servizio DB dal 21 settembre 1956 al 4 giugno 1978. Nel giugno 1982 fu acquisita da FSF che ne mantenne invariata l’immatricolazione. Nel 1999, reingegnerizzata con motore Isotta Fraschini, fu rinumerata 18 LD 220R01. Ricevette una livrea verde con riga rossa, per distinguerla da quelle con diversa motorizzazione. Nel 2009 vestiva ancora la stessa livrea: immagini più recenti non ne ho trovate.

La 006 all’epoca FSF, in testa a un convoglio di carrozze ex SBB (Leichtstahlwagen – vetture leggere in acciaio) – Foto © Maurizio Messa da http://www.trainzitaliafoto.com

La 006 nel giugno 2001, dopo la motorizzazione Isotta Fraschini. Foto: © Karl-Heinz Reichert da http://www.railroadpictures.de

La 006 nel 2009 – Foto © R.Fogagnolo da http://www.trainzitaliafoto.com
011 (FSF – FER)
La V200-011, poi 220-011-1, fu anch’essa prodotta da Mak. Espletò servizio DB dal 6 giugno 1957 al 14 ottobre 1980. il 21 ottobre 1982 fu acquisita da FSF mantenendo l’immatricolazione precedente.
Fu revampizzata e rimotorizzata CAT nel 2004: in epoca FER la sua immatricolazione è D 220.011 ER. Nella nuova livrea il suo frontale è caratterizzato da una mascherina piccola color verde muschio.

D 220.11 ER nel 2008. mascherina verde piccola.- Foto © Paolone da http://www.trainzitaliafoto.com
028 (Cosfer – FER)
La V200-028, poi 220-028-5 prodotta da Krauss-Maffei, fu in servizio DB dal 1 ottobre 1956 al 26 agosto 1981 . Nel 1982 giunse in Italia, venduta a Cosfer Tagliacozzo, e rinumerata T5662. (Altre tre immagini del periodo Cosfer si trovano su photorail.com) Nel 1997 fu ceduta a Salcef. Il 1 marzo 2003 entrò a far parte del parco FER, rinumerata D 220.028 ER. E’ caratterizzata da una mascherina grigia piccola sul frontale.

La 028 nel 2010 a Melzo scalo. Mascherina grigia piccola. Foto © alex da http://www.trainzitaliafoto.com
029 (Veltri – FER)
La V200-028, poi 220-028-3, fu prodotta da Krauss-Maffei, e restò in servizio DB dal 19 ottobre 1956 al 1 agosto 1984 . Il 4 dicembre 1984 fu venduta alla Veltri di Campoleone, e rinumerata T5719. Il 1 marzo 2003 entrò a far parte del parco FER, rinumerata 220 029-3. Ha una mascherina frontale rossa piccola.

La 029 ER, ritratta frontalmente a Cremona il Il 20.6.2009 – Foto © Massimo Minervini da trainzitaliafoto
031 (Cosfer – Comsa – Salcef)
La V200-031, poi 220-31-9, anch’essa una Krauss-Maffei, fu in servizio DB dal 2 novembre 1956 al 1 agosto 1984. A novembre 1984 giunse in Italia, venduta a Cosfer Tagliacozzo, e rinumerata T5614. Ceduta alla spagnola Comsa nel 1988, tornò in Italia per Salcef nel 1999. Non ho trovato traccia dell’evoluzione successiva.
039 (Comfer – Comsa)
La V 200-039, poi 220-39-2, prodotta da Krauss-Maffei, fu in servizio DB dal 21 dicembre 1956 al 1 agosto 1984. Venduta a Cosfer il 22 ottobre 1984, restò in Italia 4 anni.
Nel 1988 fu trasferita COMSA, Spagna, per i cantieri di costruzione della AVE e numerata 51 2904. Nel 2010 fece ritorno in Germania, dove fu ridipinta nei colori originali.

La 039 in epoca spagnola: COMSA 9-3- 71- 1-312 201-7 – Foto: © José María García de Guadiana da renfe-h0.com.
041 (Cosfer – FER)
V200-041, poi 220-041- 8. Krauss-Maffei in servizio DB dal 5 gennaio 1957 al 1 agosto 1984. Fu venduta a Cosfer il 22 ottobre 1984, e rinumerata “T5697”. Nel 1993 passò a Bulfone, che ne ha ripristinato la matricola 220-041- 8. Venne poi trasferita nel 1994 a FP. Dopo il passaggio a FER, fu revampizzata e rimotorizzata CAT nel 2005. La livrea FER è caratterizzata da una mascherina verde che si estende a V fino al centro del frontale.

FP 220-041-8 il 11.6.96 – foto © http://www.lokfotos.de

La 041 nel 2011 a Melzo scalo. Mascherina verde grande Foto © alex da http://www.trainzitaliafoto.com
045 (FP – FER)
V200-045, poi 220-045- 9. Di costruzione Krauss-Maffei, prestò servizio DB dal 2 febbraio 1957 al 21 giugno 1982. Fu venduta a FP il 12 maggio 1985. Nel 2003 fu applicata la fascia rossa antiinfortunistica. Dopo il passaggio a FER, venne revampizzata e rimotorizzata CAT nel 2005. La livrea FER è caratterizzata da una mascherina grigia che si estende a V fino al centro del frontale.

FP 045 nel 2004. Si nota la fascia antiinortunistica rossa Foto © freebyrd da http://www.trainzitaliafoto.com
049 (FSF – FER)
V200-049, poi 220-049-1. Costruita da Krauss-Maffei, fu in servizio DB dal 27 marzo 1957 al 22 agosto 1978. Venduta a FSF il 12 maggio 1982, venne revampizzata e rimotorizzata CAT nel 2002, e passata a FER nel 2003. La livrea FER è caratterizzata da una mascherina bianca (o volendo, dall’assenza di mascherina).
051 (SNFT – FER)
V200-051, poi 220-051-7. E’ una Krauss-Maffei ed operò per DB dal 15 aprile 1957 al 5 febbraio 1984. Nel marzo 1989 venduta a Jelka, e da lì passò in Italia nel 1990 a SNFT per il servizio merci sulla tratta Rovato-Breno della linea della Valcamonica per Edolo.
SNFT divenne parte di FNM nel 1994, e contestualmente la 051 (che localmente aveva acquisito il soprannome “Mazinga”) venne accantonata nel deposito di Iseo prima, e nella rimessa di Cividate Camuno poi. Era soggetta a diversi guasti: nata per le linee pianeggianti probabilmente si rivelò inadatta alla linea tortuosa e acclive della Valcamonica.
Fu poi acquisita dalla FER nel 2003, che immediatamente la sottopose al revamping con sostituzione dei motori. Fu così che la macchina, già due volte dismessa, ebbe un terza giovinezza nelle vesti tricolori di FER. In questa livrea, è caratterizzata da una mascherina piccola color verde pisello.

D220.051ER a Cremona nel maggio 2009. Mascherina verde piccola – Foto © Massimo Minervini da http://www.trainzitaliafoto.com
060 (Valditerra – Lasfed – FER)
La V200-060, poi 220-060-8, prodotta da Krauss-Maffei , fu in servizio DB dal 27 febbraio 1959 al 22 aprile 1983.
Dopo una breve parentesi presso ferrovie private Tedesche (1985-1985: Zink, Luitpoldhütte, Regentalbahn AG) fu ceduta a Valditerra (società italiana che si occupa della manutenzione dei binari) nel 1986.
Nel 1999 fu ceduta ad altra società (LAFESD), e nel 2003 pervenne a FER che, dopo averla revampizzata e rimotorizzata CAT nello stesso anno, la immatricolò 220 060. Ha una mascherina piccola verde chiaro.

La 060 appena acquisita da FER e ancora il livrea LASFEd, ritratta a Ferrara il 24/4/2003 – Foto © Stefano Paolini da photorail.com
065 (Salcef – IPE)
La V200-065, poi 220-065-7 prodotta da Krauss-Maffei , fu in servizio DB dal 26 marzo 1959 al 1 agosto 1984. Nol novembre di quell’anno fu ceduta a Layritz, Penzberg. Il 1 luglio 1985 fu venduta in Italia, probabilmente dalla SALCEF. Fu impiegata per brevissimo tempo, con immatrocolazione T 5608. Venne demolita nel 1985 alla IPE di Pradelle di Nogarole.
074 (FP – FER)
La V200-074, poi 220-074-9, prodotta da Krauss-Maffei, fu in servizio DB dal 26 marzo 1959 al 1 agosto 1984. Venne venduta a FP il 12 maggio 1984, e nel 2004, dopo il passaggio a FER, fu revampizzata e rimotorizzata CAT. La livrea FER è caratterizzata da una mascherina verde che si estende a V fino al centro del frontale.

La 074 nel 1988, quando era in forza alle FP – Foto © Maurizio Messa da http://www.trainzitaliafoto.com
076, 083 e 084
Queste tre macchine giunsero in Italia, ma di loro c’è ben poco da dire: furono acquistate da una ditta di Reggio Emilia che si occupò di demolirle.
108 – 130
La 108 fu presa in carico da Bulfone (1991) con il compito di venderla. Non fu però possibile trovare un acquirente, e la macchina fu demolita nel 2001. La storia della 130 invece fu più rapida ma altrettanto infelice: venne a Castelfranco Veneto nel 1974 solo per essere “smaltita”.
In scala N
Come anticipato, la V200 è parte importante della storia della scala N. Infatti il primo modellino nella scala N ufficiale è l’Arnold Rapido realizzato nel 1962 e mostrato nel banner di questo blog. Già nel 1960 ce n’era stata una versione in scala 1:200 (Arnold Rapido 200) e l’anno prima vi era stata la versione “Schiebetrix” non motorizzata.
La macchina è così celebre da essere poi stata realizzata in scala N da tanti produttori (Arnold, Minitrix, Roco, Fleischmann, Ibertren, Marks), per un totale di una settantina di versioni! Sono riportate sul modellbau-wiki. La grande maggioranza dei modelli riproducono la macchina in livrea originale rossa e nera, con o senza la lunga scritta sulla fiancata. Degna di menzione la versione Fleischmann digitale in doppia trazione, con una delle due unità motorizzata e l’altra folle ma provvista di sound. Poche le versioni blu-crema. Arnold ne ha prodotte anche con i ganci Simplex che permettono di effettuare manovre di sganciamento.
Tra le private tedesche, troviamo la BEG (Brohltal Eisenbahn), BEG (Bocholter Eisenbahngesellschaft mbH), BEB (Bentheimer Eisenbahn), PEG imoTrans, EGP (Eisenbahngesellschaft Potsdam), EBW Cargo (in versione V270).
Le versioni estere comprendono le svizzere, le spagnole in versione RENFE e COMSA. Quest’ultima è proprio la 51 2904 ex Comfer!
E veniamo finalmente alle italiane.
Roco (modello 23290) ha realizzato la 006 in versione FSF.
Arnold ha prodotto tra il 1983 e il 1985 il modello 2024 che riproduce la 011, anche questa in versione FSF.

Arnold 2024 – FSF 220 011 – Foto da http://www.imitidicthulhu.it/Bridge/Treni/
Sempre Arnold nel solo 1989 ha riprodotto la 045 FP (modello 2029) in verde magnolia-crema.
Nel 1993 nuovamente Roco ha guardato a noi, con il suo modello 23289 che riproduce la 051 in livrea SNFT.
A Verona 2013 Claudio Bertoli (masetro nella ripittura di modelli) aveva esposto preso la ASN la sua realizzazione di una FER.
Dulcis in fundo… E’ attesa a breve la Minitrix 12337 che riprende la 011, ma la presenta nella variopinta livrea odierna di FER.
Il nuovo negozio on-line Conrad.it vende la MiniTrix T12337 Diesellok BR D 220 der Ferrovie Emilia Romagna (FER) a 144 €. (ma il prezzo – che non include IVA! – e la data di consegna – attualmente prevista per giugno 2014 – continuano a cambiare, e non verso il basso… Visto che al primo acquisto su Conrad Italia si può ottenere uno sconto del 10% e che la spedizione è gratuita per importi superiori a 90€, la si può ottenere per circa 160 €.
Speriamo che il colore della mascherina frontale sia coerente con il numero di matricola: per la 011 dovrebbe essere verde. Niente scherzi, eh!