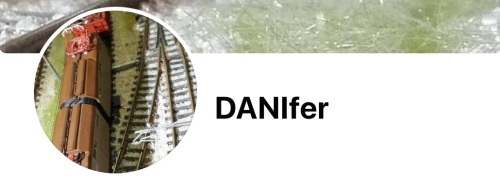pubblicato il 30 novembre 2013, ultima modifica 16 giugno 2019
La locomotiva Gr.897 è di origine prussiana: si tratta infatti della T16¹ delle Ferrovie Prussiane (poi classificata come BR 94 5-17 nelle ferrovie tedesche). Tra il 1913 ed il 1926 ne furono costruite ben 1242 unità. I due esemplari che giunsero in Italia nel 1919 come risarcimento danni per la prima guerra mondiale provenivano da Stettino ed erano pressoché nuovi di fabbrica. Anche altre nazioni ottennero macchine di questo tipo come pagamento parziale dei danni: la Francia con 21 macchine alla Compagnie des Chemin de Fer du Nord e 19 alla Compagnie des Chemin de Fer de Paris à Lyon et à la Mediterranée, 37 alla Polonia, 36 al Belgio, e 4 alla Saarländischen Eisenbahn.
In Germania queste motrici venivano usate per treni merci pesanti, ed anche per superare pendii piuttosto ripidi, sui quali erano in grado di sostituire delle macchine a cremagliera (parliamo di pendenze dell’ordine del 61 ‰ come nel caso della Boppard-Simmern).

Una Br94 impegnata nella salita da Boppard (foto da http://www.seus.net)
In Italia il potenziale di queste macchine non fu pienamente sfruttato, probabilmente anche per l’esiguo numero di esemplari disponibili. Al 31/12/1919 erano assegnate una a Milano Sempione (la 001) e l’altra ad Alessandria (la 002). La seconda fu poi trasferita al Deposito di Bologna. Furono utilizzate per servizi di manovra pesante. Chissà perchè, furono battezzate “Pierina” dai ferrovieri, che ne derivarono il nomignolo dall’appellativo con cui erano designate le perpetue dei curati di campagna nelle campagne emiliane. Restarono in servizio fino al secondo dopoguerra: il libro del Cornolò “Locomotive di preda bellica” cita la radiazione nel 1948 per la 001 ed il 1953 per la 002.

Schema delle Br94 giunte in Italia – solo la campanella non è presente. Immagine tratta da http://www.hpw-modellbahn.de/lokgeschichte
Ma torniamo in Germania per seguire la storia di queste macchine. La T16¹ è caratterizza da ben cinque assi accoppiati. Deriva dalla precedente T16, poi classificata Br 94 2-4. Questa, per favorire l’inserimento in curva, aveva gli assi estremi e quello centrale che presentavano del gioco trasversale: potevano spostarsi lateralmente di 26 mm. Questo portava a incernierare la biella motrice sulla quarta sala: la stessa soluzione presentata dalla KKstB 180, poi FS Gr.477. La lunga biella provocava però un andamento irregolare, per cui dal 1909 la soluzione fu modificata incernierando la biella sul terzo asse, che non poteva più avere gioco laterale e per questo ebbe ruote con bordino ridotto. La macchina era così in grado di percorrere curve con raggio di 200 m. La storia della evoluzione della T16 è documentata in un bell’articolo di Andrea Luigi Meneghini su trainzitaliafoto.
Nel 1913 esordì la versione potenziata della macchina, che fu denominata T16¹ ed in epoca DR ebbe classificazione Br 94 5-12. Si distinguono facilmente dalle T16 precedenti per la casse dell’acqua che presentano la parte anteriore superiore inclinata, come si può osservare negli schemi sottostanti. Le ultime macchine della serie furono costruite nel 1924: quindi come già detto le due macchine che le FS ricevettero non erano, come in altri casi, delle motrici ormai anziane, ma delle macchine allo stato dell’arte.

Varie evoluzioni della T16 – poi Br 94. Immagine tratta da http://www.hpw-modellbahn.de/lokgeschichte, originale da Moderne Eisenbahn del 1965
Come quasi sempre accade, specie nel caso di gruppi così numerosi e prodotti in un arco temporale piuttosto esteso, della macchina vi furono varie versioni che differivano per dei dettagli. I più evidenti tra questi sono la carboniera, che poteva essere alta o bassa (come nel caso delle “italiane”), la forma dell’imperiale, il numero e la posizione di duomi e sabbiere (il secondo duomo fu aggiunto nel 1921).

T16¹ delle ferrovie polacche (PKP): TKw-2-114 (con carboniera bassa) a Chabowka nel 2006, foto Wassen da wikimedia
In Germania Ovest alcune macchine furono operative fino gli anni ’70: le ultime lasciarono il servizio nel 1974, mentre pare che in Germania Est siano rimaste in esercizio anche per qualche altro anno. Cinque o sei macchine furono preservate in condizioni operative, ma non furono poi in grado di resistere alle ingiurie del tempo. L’ultima operativa (la 94 1538) fu fermata nel 2012 da un serio danno alla caldaia.
Una macchina è conservata in Austria nel Lokpark Ampflwang. Due macchine sono preservate in musei dell’Est Europa, dove avevano prestato servizio dopo essere state cedute in riparazione dei danni di guerra: una è nel museo di veicoli e sistemi ferroviari in Chabówka in Polonia (ex TKw2-114 94 729), l’altra nel Museo Ferroviario Sibiu in Romania (94 549). Una piccola galleria di foto delle Br94 polacche si trova su holdy.pl/tomi
Come curiosità citiamo il fatto che la denominazione T16 era in precedenza stata attribuita ad una macchina sperimentale completamente diversa, ma molto interessante: una motrice con due cabine e con rodiggio simmetrico 2-C-2. Nonostante l’omonimia, la macchina non ha parentela alcuna con le T16 nate nel decennio successivi e delle quali abbiamo parlato qui.
Nel modellismo
La BR 94 (T16¹) è riprodotta in molte scale, dalla 1 alla Z. La versione FS è stata realizzata sia in H0 e in N, in entrambi i casi da Fleischmann, che in H0 riprodusse (a partire dal 2010) sia la “milanese” Gr.897.001 (cat. 409403) che la “bolognese” Gr.897.002 (cat. 409404), mentre in N si limitò alla prima. In realtà la Fleischmann Piccolo 7095, a catalogo tra il 1979 e il 2007, era una versione “nuda” e completamente nera dotata di decals di varie amministrazioni (ÖBB, SNCF, SNCB, NS, FS, RAG) per la localizzazione, e per di più a carboniera alta. Meglio l’approssimazione offerta dalla loco tedesca con le ruote rosse! (ma su questo punto torneremo).
Le H0 di Fleischmann (la 409403, versione Gr.897.001 e la 409404, versione Gr.897.002) sono interessanti. Presentano la carboniera di dimensione ridotta come effettivamente si aveva nelle macchine italiane.
Dal confronto tra le versione in N e la H0 italiana (o, meglio, con la foto dell’originale), si può notare come a parte la carboniera la modifiche evidenti siano poche: nella versione italiana la campanella nella parte frontale sopra la caldaia è rimossa, e le lanterne hanno forma un po’ differente. Fortunatamente numero, forma e posizione dei duomi coincidono!
La 002 è caratterizzata dal fatto di avere sulla cabina la targa rossa invece delle scritte che caratterizzano l’immediato periodo postbellico.
In precedenza Fleischmann aveva italianizzato la Br94 senza modificarne la carboniera, come si vede nella seguente immagine della 897.002 (che presenta anche la targa nera-oro di epoca intermedia invece della targa rossa).
Tornando alla scala N, troviamo (sempre da Fleischmann) vari modelli di BR94, tra cui quello “internazionale” di cui abbiamo già detto. Differiscono per alcuni particolari, i più evidenti dei quali sono le forme del tetto e della carboniera. Il tetto della cabina può infatti essere tondo (modelli 7091 e 7093) o con gli aeratori, che ne rendono piatta la sezione centrale (modelli 7092, 7094 e 7095).
Inoltre tutti i modelli in N a parte uno (7091) hanno la carboniera alta. Quest’ultimo però ha il fumaiolo lungo (ma è più facile accorciare il fumaiolo che ridurre la carbonaia!
Insomma, il paradosso è che la versione venduta come “italiana” (7095) è la più sbagliata, mentre la 7091 con la sola rimozione della campana e l’applicazione di decals opportune (e magari una brunitura del biellismo) diventa un bel modello di FS Gr. 897!

Fleischmann 7091 con stanghe brunite, fumaiolo accorciato, campana rimossa e decals applicate (foto e modello di Claudio Bertoli)
Per gli amanti del dettaglio, FineScale offre delle sale con ruote molto meglio definite, e con bordino più sottile. Qui sono mostrate sulla 94.5 tedesca. Molto belle, cambiano davvero l’aspetto della macchina: 196 € montate…

Ruote rifinite e ribassate, da MaGo FiNescale (foto da http://www.mago-finescale.de/)

Una sala con ruote rifinite e ribassate, da MaGo FiNescale (foto da http://www.mago-finescale.de/)
Per le decals, in teoria dovrebbero essere disponibili quelle di Blaine Bachmann ma credo che la serie di decals per le vaporiere non sia mai stata ultimata.

Un’altra FS Gr. 897 in scala N. Bel modello, carboniera e fumaiolo corretti, ma con qualche difetto: andrebbe rimossa la campana, e l’imperiale non è quello arrotondato, e le decals (694.503) sono proprio sbagliate… Paolo Angioy, proprietario del modello, sicuramente rimedierà…
Se uno si trova invece a partire da un modello diverso dal 7091, può sempre rimediare. Come modificare un modello tedesco per ottenere una “Pierina” è descritto in un articolo su Pescaraferr. Gli “accazeristi” sostituiscono anche le pompe ed alcune tubazioni (v. izzomelis o xhero o piroen), ma per il modello in scala N forse sarebbe un impazzimento, oltre che un livello di dettaglio quasi maniacale.
Fabrizio Mazziero si è cimentato in un lavoro che ha agito anche su alcuni dettagli, documentando il suo lavoro sul forum ASN. Le operazioni compiute, partendo dal modello Fleischmann 7091, sono state:
- rimozione delle scritte (numeri di serie)
- rimozione della campanella
- abbassamento del fumaiolo (che nel modello è più alto)
- rimozione dei due tubi situati nella parte anteriore della caldaia
- rimozione della targa situata sullo sportello anteriore della caldaia
- rimozione del gancio anteriore con tutto il suo alloggiamento
- rifacimento del gancio anteriore e il tubo della pressione
- rifacimento della ringhiera anteriore e dei gradini nella parte inferiore
Sarebbe stato necessario cambiare con un solo bombolone un po’ più grosso i due sotto la carboniera, ma l’operazione era rischiosa per cui non è stata effettuata (notiamo che anche i modelli H0 hanno il doppio bombolone).
Il notevole risultato è documentato fotograficamente (prima della aggiunta delle decals).
Le qualità di marcia Fleischmann sono tra le migliori per quanto riguarda i modelli industriali. E’ possibile migliorarle ulteriormente sostituendo il motore con un Faulhaber o con un Maxon.

Motore Faulhaber montato sul telaio Fleischmann (foto da http://www.mago-finescale.de/)
Infine, si può pensare di digitalizzare la loco, magari con un sound decoder. La modifica è documentata su 1001.digital.de. Lo spettacolare risultato è documentato nel seguente video.
Aggiornamento 2018:
Fleischmann ha deciso di rimediare ai suoi errori. Attualmente vende il modello 709404 in versione FS quasi giusta (basta togliere la campana). Peccato che non abbia la slot per il decoder.
Nella serie “Vapore italiano”:
- FS Gr.422 (ex G8 – Br 55.16-22) con cenni ai Gr.421 e 425 (ex G7 – Br55.0-6 e 7-14)
- FS Gr.423, 424, 452, 453, 454, 455
- FS Gr 460 (ex G8¹ – Br 55.25-57)
- FS Gr.473 (ex G10 – Br 57), con cenni alla Gr.474
- FS Gr. 477, 728, 729, 877, 893 e 899 (con cenni al Gr. 876)
- FS FS Gr.897 “Pierina” (ex T16¹ – Br 94) (questo articolo)
- Mallet Italiane (FS R.440, R.442, R.450, R.600) ed Europee
- Le vaporiere di Cantarella (ArMo): Gr.740, 743, 741, 691, 746, 940, 470, 670